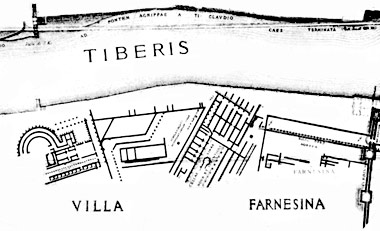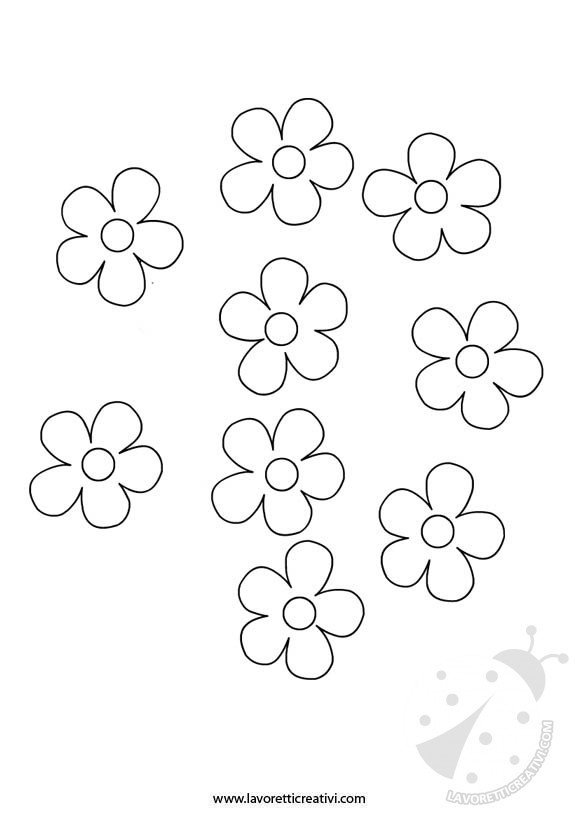‘Epepe’ di Ferenc Karinthy suggerisce che la vera antiutopia sia l’alienazione completa dalla possibilità di comunicare con altri esseri umani. Che l’essenza del male sia l’incomprensione. Budai, il protagonista del romanzo pubblicato dallo scrittore ungherese nel 1970, è un linguista che fa scalo verso Helsinki, diretto a un convegno, solo per addormentarsi sul volo sbagliato e riprendere conoscenza in una metropoli (in inglese il testo è intitolato ‘Metropole’) in cui nessuno comprende alcuna della dozzina di lingue da lui correntemente parlate. Si trova in un albergo, privato del passaporto, e con 200 unità della moneta locale: ma è tutto ciò che gli è concesso.
‘Epepe’ di Ferenc Karinthy suggerisce che la vera antiutopia sia l’alienazione completa dalla possibilità di comunicare con altri esseri umani. Che l’essenza del male sia l’incomprensione. Budai, il protagonista del romanzo pubblicato dallo scrittore ungherese nel 1970, è un linguista che fa scalo verso Helsinki, diretto a un convegno, solo per addormentarsi sul volo sbagliato e riprendere conoscenza in una metropoli (in inglese il testo è intitolato ‘Metropole’) in cui nessuno comprende alcuna della dozzina di lingue da lui correntemente parlate. Si trova in un albergo, privato del passaporto, e con 200 unità della moneta locale: ma è tutto ciò che gli è concesso.
È qui che poco alla volta, lucidamente, senza mai rinunciare al proprio raziocinio, Budai testimonia che senza la possibilità di guardarci attraverso le parole degli altri, di sentirci compresi da io che non siano il nostro, vacilliamo, diventiamo noi stessi frammenti insignificanti di un’umanità insignificante, abbandonata a un giudizio su cui non abbiamo alcun modo di intervenire. Come la vita quotidiana di Budai: una ripetizione infinita di gesti privi di senso nonostante siano tutti razionalmente indirizzati al tentativo di comprendere l’accaduto, in che luogo sia finito, perché, e quando avrà termine il supplizio.
Diversi recensori sottolineano come la distopia di Karinthy si possa e debba leggere come una satira della Mosca di Breznev, specie – scrive Francesco Peri – vista “con gli occhi di visitatore Occidentale degli anni ’70”; e i fatti della rivolta ungherese del 1956 affiorano tra le pagine finali, nell’insurrezione popolare – di nuovo, completamente incomprensibile, quasi casuale nel suo darsi – prima pacifica, perfino gioiosa e poi armata, perché repressa dai carri armati, di cui il protagonista si trova a essere parte. Ma l’atmosfera che si respira nel romanzo è anche e soprattutto astratta, dell’astrazione dello Swift de ‘I viaggi di Gulliver’, dello Skinner di ‘Walden Two’, del Saramago di ‘Cecità’ e del migliore H. G. Wells.
Semplice il rimando a Kafka, ma come sottolinea Emmanuel Carrère nella prefazione alla nuova edizione italiana curata da Adelphi sono il rigore fiducioso e la tenacia disperatamente calcolatrice di Budai a costringerci a prenderne le distanze. Anche se un pensiero resta, alla fine della lettura: e se la metropoli non fosse che la metafora di un’immensa punizione tutta architettata contro il protagonista? Se la burocrazia terrorizzante del ‘Processo’ fosse semplicemente trasposta in architetture, edifici costruiti senza sosta, luoghi, code infinite di esseri senza futuro, grandi magazzini inutilmente affollati, strade e stazioni che conducono ovunque tranne che altrove?
È questa, credo, l’essenza dell’incubo di Karinthy, e il motivo per cui a mezzo secolo dalla stesura risulta ancora così pungente: come si scappa da una prigione in cui nessuno ti comprende? È il terrore del perfetto isolamento da ciò che ci circonda che assale quando visitiamo luoghi radicalmente alieni alla nostra cultura e abitudini, ma è anche tutto sommato una riedizione perfino più spietata dell’orwelliana riscrittura della storia. Cos’è il passato se non abbiamo un modo condiviso per dirlo? Cosa in un luogo che attraverso la lingua – e dunque la base del pensiero – è perfettamente isolato non solo dal resto del mondo, ma perfino da se stesso? Budai lo annota ripetutamente, nei suoi tentativi di decifrare una lingua che, come la storia di Orwell, sembra continuamente cangiante, diversa, mutevole nonostante intenda lo stesso: perfino gli abitanti di quello strano paese sembrano non capirsi tra loro, parlare tante lingue quanti sono gli individui.
È questa forse una delle risorse più terribili per un potere che fosse in grado di comandare quella Babele: l’incomprensibilità è un modo per riscrivere l’umano, riprogrammare i sentimenti, redirigere i passi e mutare ogni gesto quotidiano. In molte narrazioni antiutopiche, l’amore è la salvezza – e la figura femminile, sempre compromessa con il difforme, ne è il disvelamento. ‘Epepe’ non fa eccezione: la donna dal nome incerto – Pepe, Bebe, Edede, Epepe – che accompagna Budai al piano, in ascensore, è l’unica persona che definiremmo comunemente tale. Cerca di interessarsi al suo spaesamento, prova a porvi rimedio con lunghe soste al diciottesimo piano, riesce perfino a scatenare in lui reazioni irrazionali – l’attrazione, la violenza. Ma non basta a salvarci, sembra suggerire Karinthy. Nemmeno ciò che non si esprime a parole ha senso, senza parole che significano.